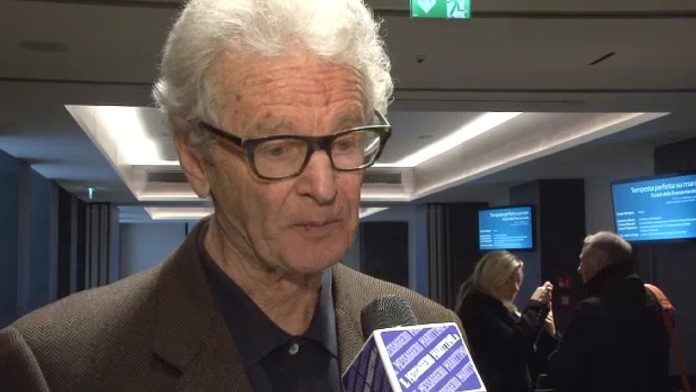
Gli smemorati: Riflessioni (amare) sulla crisi italiana
di Sergio Bologna –
La memoria corta è un tipico difetto italico. Pronti a entusiasmarci per il nuovo arrivato sulla scena politica che promette quello che tutti, prima di lui, hanno promesso e nessuno ha realizzato, ci dimentichiamo allegramente le vicende, di cui tutti siamo corresponsabili, che ci hanno portato a questo punto: a una crisi che, al di là di quello che ci raccontano e ci raccontiamo, è crisi di sistema, che richiede, appunto, un cambiamento di sistema. Davvero viviamo in tempi oscuri, come scriveva tanti anni fa un grande poeta tedesco dimenticato, e l’umore non può essere che nero, come quello di Sergio Bologna. Ma ricordare fa sempre bene.
Ricevo le newsletter che vanno per la maggiore, lavoce.info, sbilanciamoci, nel merito.com ed altre, leggo ogni tanto Huffington Post, mi capita anche eccezionalmente di buttare l’occhio sui quotidiani, navigo su Reuters, Bloomberg, l’Economist, FT e chissà perché alla fine ho sempre la sensazione che manchi qualcosa nei ragionamenti sulla crisi italiana, qualcosa di grosso, non un dettaglio. Ed allora provo a ricominciare daccapo, mettendo in fila gli avvenimenti, per vedere se sono i miei occhiali che non funzionano più oppure quelli dei validissimi esperti, 95% dei quali economisti, docenti universitari, che redigono con abnegazione le suddette fonti con il nobile intento di far capire alla gente dove andremo a finire. Un vero servizio sociale fornito gratuitamente, un esempio di encomiabile volontariato. Ma che rischia di essere inutile.
Comincerei con due domande. Quando è iniziato il declino di Berlusconi? Quando in questo paese c’è stato un momento in cui i cittadini hanno dato segni evidenti di non sopportare più la combriccola PdL-Lega-AN? Risposta: durante la campagna elettorale per il sindaco di Milano. Non è stata – chi l’ha vissuta non può negarlo – una campagna elettorale come le altre, la passione e l’entusiasmo popolare, la  mobilitazione spontanea, di massa, erano qualcosa di eccezionale, soprattutto in un paese dove l’astensionismo ormai si avvicina al 50% degli aventi diritto. Non era la solita stucchevole scaramuccia tra partitocrazie sotto gli occhi indifferenti della gente. Era un vero movimento democratico, che ha inflitto al centro-destra una sconfitta tanto più bruciante in quanto ottenuta nella culla del leghismo e del berlusconismo. Non contano tanto i risultati in termini di percentuali, la vera grande novità di quelle giornate era data dalla fine di un’epoca buia di apatia, di qualunquismo, di cialtroneria, di volgarità, di cinismo, epoca iniziata con la “Milano da bere” craxiana, rinforzata da una deriva del Partito Comunista la cui unica soddisfazione era quella di esser riuscito a mandare in galera la generazione post 68. La Milano di Craxi e la Milano di Occhetto, la Milano che combinava glamour e tangenti, mentre l’occhio vigile di Napolitano spingeva il gregge verso la Bolognina. Su questa miseria di valori e di prospettive dei partiti che una volta costituivano il cosiddetto movimento operaio, Comunione e Liberazione allargava a macchia d’olio la sua influenza e costruiva il vero sistema di potere che ancor oggi governa la città. Su questa miseria di valori e di prospettive del centro-sinistra Berlusconi e la Lega hanno potuto costruire le loro fortune politiche. La vittoria di Pisapia quindi chiudeva un’epoca o, almeno, noi c’illudevamo che fosse così. Ma comunque sia era una
mobilitazione spontanea, di massa, erano qualcosa di eccezionale, soprattutto in un paese dove l’astensionismo ormai si avvicina al 50% degli aventi diritto. Non era la solita stucchevole scaramuccia tra partitocrazie sotto gli occhi indifferenti della gente. Era un vero movimento democratico, che ha inflitto al centro-destra una sconfitta tanto più bruciante in quanto ottenuta nella culla del leghismo e del berlusconismo. Non contano tanto i risultati in termini di percentuali, la vera grande novità di quelle giornate era data dalla fine di un’epoca buia di apatia, di qualunquismo, di cialtroneria, di volgarità, di cinismo, epoca iniziata con la “Milano da bere” craxiana, rinforzata da una deriva del Partito Comunista la cui unica soddisfazione era quella di esser riuscito a mandare in galera la generazione post 68. La Milano di Craxi e la Milano di Occhetto, la Milano che combinava glamour e tangenti, mentre l’occhio vigile di Napolitano spingeva il gregge verso la Bolognina. Su questa miseria di valori e di prospettive dei partiti che una volta costituivano il cosiddetto movimento operaio, Comunione e Liberazione allargava a macchia d’olio la sua influenza e costruiva il vero sistema di potere che ancor oggi governa la città. Su questa miseria di valori e di prospettive del centro-sinistra Berlusconi e la Lega hanno potuto costruire le loro fortune politiche. La vittoria di Pisapia quindi chiudeva un’epoca o, almeno, noi c’illudevamo che fosse così. Ma comunque sia era una  rottura, non nei numeri ma nei modi del vivere la politica, non perché si erano prodotte fratture nel quadro partitico (SEL) ma perché i cittadini, la gente, i giovani avevano ritrovato le ragioni per scendere in strada, in maniera festosa, pacifica, politically ipercorrect. Ed era, è ancora, questa l’unica modalità che avrebbe portato, che può portare, alla vittoria. Tutto il resto, gli stanchi riti delle primarie dove il gregge vota quel che dicono i giornali e se i giornali dicono Renzi vota Renzi, se dicono Pippo Baudo vota Pippo Baudo, tutto il resto è noioso avanspettacolo.
rottura, non nei numeri ma nei modi del vivere la politica, non perché si erano prodotte fratture nel quadro partitico (SEL) ma perché i cittadini, la gente, i giovani avevano ritrovato le ragioni per scendere in strada, in maniera festosa, pacifica, politically ipercorrect. Ed era, è ancora, questa l’unica modalità che avrebbe portato, che può portare, alla vittoria. Tutto il resto, gli stanchi riti delle primarie dove il gregge vota quel che dicono i giornali e se i giornali dicono Renzi vota Renzi, se dicono Pippo Baudo vota Pippo Baudo, tutto il resto è noioso avanspettacolo.
Pisapia inizia a governare con bravissime persone, alcune non proprio bravissime se le toglierà dai piedi, ma pensa che governare in silenzio, mettendo a posto i conti, con scrupolo, da bravi amministratori possa bastare e qui sbaglia, avrebbe dovuto rompere le regole del costume politico e imprimere invece una gestione plebiscitaria al governo del Comune, in modo da tener desta quella fiamma di partecipazione entusiasta che era il patrimonio più prezioso cui attingere per tenere lontano il pericolo di un ritorno di Berlusconi, un patrimonio inestimabile da cui trarre linfa per una re-invenzione della città, molto più prezioso di tanti scrupolosi revisori dei conti. Non l’ha fatto, la cultura politica della sua cerchia non lo prevede.
E arriviamo alle elezioni politiche del febbraio 2013, attraverso un passaggio stretto, strettissimo, costituito dalla crisi, che si prolunga dopo i facili ottimismi del 2010, e dalla messa sotto tutela del nostro Paese da parte delle burocrazie di Bruxelles. Qui c’è da segnalare solo il tentativo di Napolitano di mantenere in vita il berlusconismo senza Berlusconi e di voler ostinatamente insistere sulla tecnocrazia come rimedio al populismo. Monti produrrà più danni di Tremonti ma intanto s’inaugura la serie di governi che rispondono solo a Bruxelles e ai “mercati finanziari internazionali” – questa entità evanescente che però esercita la più crudele delle dittature. Il custode della Costituzione realizza il sogno berlusconiano di una Repubblica presidenziale ma intesa come luogotenenza della Commissione Europea. La Costituzione uscita dalla resistenza antifascista non poteva essere… in più buone mani e la dimostrazione avviene dopo le elezioni del febbraio 2013. Otto milioni e mezzo di votanti voltano le spalle al centro-destra, qualche milione anche al PD, ma per offesa alla volontà popolare, che si era espressa in maniera inequivocabile, il custode-luogotenente, con il consenso maggioritario del PD e dei poteri economici, mediatici e sindacali, promuove quel governo delle “larghe intese” ovvero dei due Letta (Enrico e Gianni) che per prima cosa riconsegna a un Berlusconi massacrato sul campo un potere d’interdizione nel governo. In nome della governabilità, il custode della Costituzione l’ha proprio messa sotto i piedi, rivelandosi ancora una volta non uomo di parte ma di partito, perché mantenere in piedi un berlusconismo morente e permettergli di riprendere fiato è il modo migliore per mantenere in vita il PD (ripeto: con il consenso maggioritario dei poteri economici, mediatici e sindacali). I due schieramenti restano in piedi perché si tengono su l’uno con l’altro.
A questo punto Letta Enrico compie il suo capolavoro, superando di colpo gli equilibrismi del custode-luogotenente: pur di riconoscere apertamente il potere d’interdizione di Berlusconi, pur di rimarcare la sua ri-legittimazione, accetta il ricatto dell’IMU e combina, assieme ai suoi ministri, una delle più oscene nefandezze che mai la politica italiana è riuscita a perpetrare a danno dei cittadini. Qui lascerei la parola ad un qualunque commercialista, io non riuscirei a trovare parole  più dure di lui. Gli lascerei la parola anche perché a me preme mettere in evidenza un’altra cosa: facendo saltare l’IMU, Berlusconi metteva in conto anche d’infliggere un colpo mortale agli equilibri di bilancio delle città metropolitane e non solo, l’effetto collaterale era di mettere in difficoltà la giunta Pisapia, poteva essere la sua vendetta per la bruciante sconfitta subita a Milano. Ed i suoi alleati politici del centro-sinistra, i suoi alleati istituzionali, un pensierino volete che non l’abbiano fatto? Ma certo, a fregarsi le mani all’idea di poter uccidere un altro movimento di massa, un’altra spinta autenticamente democratica, un’altra speranza giovanile. La Milano delle piazze piene di entusiasmo e di passione civile doveva morire, anche se pacifica, anche se buonista. Pisapia c’entra fino a un certo punto, quello che inquieta questo sistema dei partiti è il protagonismo dal basso, anche quello politically ipercorrect. Il governo Letta, fatto di gente navigata, sarà ricordato solo per questo: per l’irresponsabilità con cui ha trattato il comune cittadino proprietario di un immobile o il piccolo imprenditore proprietario di un capannone, per il disprezzo verso le istituzioni comunali ed i cittadini che a quelle fanno riferimento, per le violenze contro i No Tav e l’assoluta libertà di movimento e di sabotaggio lasciata al movimento dei forconi. Pretendere che Renzi rappresenti una rottura verso la storia del partito da cui proviene o di quella delle istituzioni che gli hanno dato l’investitura, è chiedere troppo. Nemmeno Sansone, nemmeno il tebano figlio di Alcmena ci sarebbero riusciti.
più dure di lui. Gli lascerei la parola anche perché a me preme mettere in evidenza un’altra cosa: facendo saltare l’IMU, Berlusconi metteva in conto anche d’infliggere un colpo mortale agli equilibri di bilancio delle città metropolitane e non solo, l’effetto collaterale era di mettere in difficoltà la giunta Pisapia, poteva essere la sua vendetta per la bruciante sconfitta subita a Milano. Ed i suoi alleati politici del centro-sinistra, i suoi alleati istituzionali, un pensierino volete che non l’abbiano fatto? Ma certo, a fregarsi le mani all’idea di poter uccidere un altro movimento di massa, un’altra spinta autenticamente democratica, un’altra speranza giovanile. La Milano delle piazze piene di entusiasmo e di passione civile doveva morire, anche se pacifica, anche se buonista. Pisapia c’entra fino a un certo punto, quello che inquieta questo sistema dei partiti è il protagonismo dal basso, anche quello politically ipercorrect. Il governo Letta, fatto di gente navigata, sarà ricordato solo per questo: per l’irresponsabilità con cui ha trattato il comune cittadino proprietario di un immobile o il piccolo imprenditore proprietario di un capannone, per il disprezzo verso le istituzioni comunali ed i cittadini che a quelle fanno riferimento, per le violenze contro i No Tav e l’assoluta libertà di movimento e di sabotaggio lasciata al movimento dei forconi. Pretendere che Renzi rappresenti una rottura verso la storia del partito da cui proviene o di quella delle istituzioni che gli hanno dato l’investitura, è chiedere troppo. Nemmeno Sansone, nemmeno il tebano figlio di Alcmena ci sarebbero riusciti.
La crisi. Qui c’è un’altra smemoratezza che grida vendetta. Com’è possibile continuare a parlare di crisi tirando in ballo i mercati finanziari, la Merkel, il patto di stabilità, i costi della politica, l’evasione fiscale, il costo del lavoro, le politiche di austerità, lo spread, la globalizzazione, i Brics, l’euro e chi più ne ha più ne metta e dimenticarsi che una delle ragioni di fondo della nostra crisi di sistema sulla quale si è rovesciata la crisi internazionale, creando il disastro che è sotto gli occhi di tutti, è stata la sfiducia del medio-grande imprenditore verso la propria azienda. C’è stata una vera e propria fuga dagli investimenti produttivi, soprattutto dagli investimenti in innovazione, da parte di una generazione di imprenditori o di azionisti che prima hanno preferito dirottare le risorse sui prodotti finanziari e sull’immobiliare, poi, anzi contestualmente, hanno puntato le carte su un business model centrato sull’abbattimento del costo del lavoro e delle retribuzioni. Costo del lavoro che finora non è stato abbattuto e retribuzioni che sono state abbattute due volte: con la compressione dei salari ai dipendenti e l’uso massiccio di contratti flessibili, a termine, verso i precari. Solo un ristretto gruppo di medie imprese ha continuato a investire, perlopiù del settore meccanico, e non a caso non hanno sofferto della crisi, continuano ad esportare, a crescere in Italia e all’estero. Pochissime di loro appartengono al settore del made in Italy, che invece rappresenta il modello perfetto d’impoverimento del capitale umano, di delocalizzazione produttiva, di sfruttamento della mano d’opera dei paesi poveri. Il made in Italy, soprattutto nel settore fashion e abbigliamento, è una devastante macchina di produzione di cultura dell’effimero, dell’apparenza, d’immaginari tanto infantili quanto grotteschi, ha partorito una generazione di esseri vuoti, convinti che la personalità sia componibile con accorgimenti di shopping, esseri senz’anima, capaci di negoziare un mutuo ma non di dire una frase che possa distinguerli dal mondo degli insetti. Laureati. E quella imprenditoria che nulla conserva degli “spiriti animali” di schumpeteriana memoria non è stata più in grado di riprodurre una borghesia con un minimo profilo di stile, ma si è confusa con quella terziaria, intermediaria, volgare, sbracata, arrogante, chiassosa, cialtrona, che non conserva il minimo tratto di quel modo di essere di una classe che bene o male ha forgiato la nostra civiltà occidentale. Ma può essere più “brutto”, più merdoso, il ricco italiano? “Ti fa passare anche la voglia di sparargli in bocca” sentii dire un giorno da un compagno che aveva fatto la galera.
Dopo la distruzione della grande chimica, dell’industria dell’auto, della siderurgia, dell’elettronica, dopo la cessione a gruppi esteri di buona parte dell’alimentare o dell’agroindustria, delle telecomunicazioni, la graduale dissoluzione dei distretti, la sostituzione del capitale industriale con la rendita ha lasciato libero il campo al private equity di vista corta e di guadagni rapidi oppure a quella che viene chiamata (ed esaltata) come “finanza d’impatto”, ultima spiaggia, assieme alla green economy, per un rilancio delle economie occidentali. Ma l’inchiesta che “sbilanciamoci” ha appena finito di pubblicare su questa impact finance toglie molte illusioni. Allora occorre concludere che non c’è speranza di uscire dalla crisi se la base manifatturiera e lo spirito imprenditoriale sono un fenomeno residuale concentrato solo nella piccola e micro impresa. Invece di prenderne atto e di chiedersi se l’orizzonte della competitività sia ancora quello giusto per ragionare di rilancio dell’economia e dell’occupazione, la totalità di coloro che ci spiegano come si potrebbe uscire dalla crisi si abbandona a ragionamenti macroeconomici, per l’80% legati alle politiche fiscali e monetarie, alle decisioni della BCE o ai voleri della Merkel e quando da queste alte sfere passa alle politiche attive di rilancio o si ferma alla produzione di moneta e all’inflazione programmata o ripete le formule keynesiane di stimolo della domanda di competenza dei poteri pubblici, coniate in piena epoca fordista, quando corporations, sindacati e pubblica amministrazione potevano concertare qualcosa che doveva imporsi anche al mondo della finanza. Quando cioè era ipotizzabile un minimo di governance del sistema. Oggi questo è irripetibile con la società “liquida” che ci ritroviamo, ma è irripetibile soprattutto nell’Italia della microimpresa e del lavoro indipendente, del precariato e della disoccupazione giovanile. Pertanto, siccome gli economisti sono fatti con lo stampino, di qualunque scuola facciano parte, non è da loro che può venire un aiuto. Nella storia economica non c’è più stata una teoria specificamente anti-crisi dopo Keynes, cioè dopo la crisi del ’29, e quello che è stato fatto nell’immediato dopoguerra, la ricostruzione, non è riproducibile. Dopo il ’45 si costruivano case perché la gente dormiva per strada, oggi si costruiscono per lasciarle vuote. Nessuno oggi, né il più fetente banchiere né il più benintenzionato economista ha in tasca la formula per far riprendere l’economia nei paesi avanzati, per imporre uno sviluppo con occupazione, per disciplinare, regolamentare, correggere il corso degli eventi, per introdurre degli elementi esogeni nel funzionamento del sistema. Pertanto tutto continuerà così come va avanti adesso, produzione di iperricchezze e proliferazione di povertà, crescita del PIL e diminuzione dell’occupazione (vedi ultimo Rapporto ILO). Quindi è inutile chiedere a un governo di fare qualcosa “di sinistra”, di emettere qualche vagito socialdemocratico. Non si chieda a Renzi quel che Renzi non può dare. Non ci sono ricette di politica economica, non ci sono azioni di governo che possano cambiare le cose, al massimo, nel migliore dei casi – e con grande sforzo, superando mille resistenze – si può evitare di peggiorarle. E noi il meglio che possiamo fare è galleggiare, sopravvivere, darci la mano per resistere. L’unica incognita che può, potrebbe, cambiare le cose è un conflitto sociale non episodico, sistematico, con un grado crescente di radicalità e un segno ben chiaro di riappropriazione di risorse comuni, patrimoniali e ambientali, culturali ed economiche, di cui quotidianamente veniamo espropriati.






