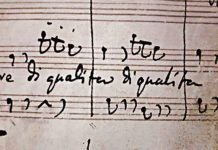Felicità ed etica sociale
di Amartya Sen –
 Il tema “Felicità e disuguaglianze” suggerito dagli organizzatori di questo meraviglioso festival è molto più ampio di queste circostanze specifiche. Provo a fare il mio dovere parlando prima di una questione più ampia: il posto e la rilevanza della felicità non solo per la vita individuale ma anche per quella della società, per la vita sociale insomma. Ci rientreranno le disuguaglianze, perché in effetti parlerò di “Felicità e istituzioni sociali” – o di “Infelicità e istituzioni europee” – e in questo quadro più ampio, la disuguaglianza conta. Dopo un’analisi generale tornerò alla crisi economica europea per illustrare alcuni aspetti collegati al tema che mi era stato assegnato.
Il tema “Felicità e disuguaglianze” suggerito dagli organizzatori di questo meraviglioso festival è molto più ampio di queste circostanze specifiche. Provo a fare il mio dovere parlando prima di una questione più ampia: il posto e la rilevanza della felicità non solo per la vita individuale ma anche per quella della società, per la vita sociale insomma. Ci rientreranno le disuguaglianze, perché in effetti parlerò di “Felicità e istituzioni sociali” – o di “Infelicità e istituzioni europee” – e in questo quadro più ampio, la disuguaglianza conta. Dopo un’analisi generale tornerò alla crisi economica europea per illustrare alcuni aspetti collegati al tema che mi era stato assegnato.
«O gente umana, per volar sù nata, perché a poco vento così cadi?» lamenta Dante nel canto XII del Purgatorio. Perché questo contrasto tra la vita limitata della maggior parte delle donne e degli uomini e le grandi imprese che riescono a compiere? La domanda posta all’inizio del Quattrocento è ancora attuale. Le nostre potenzialità di avere una vita buona, di essere appagati, felici, liberi di scegliere il tipo di vita che vogliamo, eccedono di lunga quelle che riusciamo a realizzare.
La vulnerabilità umana deriva da svariate influenze, ma una delle fonti principali del nostro limite – e anche della nostra forza, dipende dalle circostanze – è che la nostra vita individuale dipende dalla natura della società in cui stiamo. La natura del problema è ben illustrata dalla crisi che ha colpito l’Europa negli ultimi anni, dalla sofferenza e dalle privazioni che incidono sulla vita in Italia e in Grecia, in Portogallo e in Gran Bretagna, in Francia e in Germania, in quasi tutta l’Europa. Non solo per l’Europa di oggi ma anche per quella futura, è un disastro dalle cause complesse e dobbiamo sondarne la genesi, l’accentuarsi e la persistenza.
Sarebbe difficile capire la condizione degli esseri umani coinvolti in questa tragedia senza studiare come ci abbia contribuito, in modi diversi, il malfunzionamento delle istituzioni che ne governano la vita: il ruolo dei mercati e delle istituzioni a essi collegati, ma anche delle istituzioni statali e delle autorità regionali.
Non c’è dubbio che la felicità sia un’ottima cosa ed è ovvio che abbiamo ottime ragioni per perseguirla. Ma non è l’unica e un problema sorge quando cerchiamo di occuparci di etica sociale basandoci soltanto sul criterio della felicità, come fa l’utilitarismo. Di recente questa prospettiva è tornata in auge, ma è una visione molto limitata dell’etica sociale. Presenta due problemi distinti: anche se il metro della felicità è un buon mezzo per misurare il benessere individuale, l’etica sociale non può concentrarsi esclusivamente su tale benessere, e non è affatto chiaro che la felicità ne sia un indicatore affidabile.
Un limite di questo approccio, di cui l’utilitarismo è un esempio, sta nel fatto che uno stesso insieme di forme di benessere può accompagnarsi a dispositivi sociali, opportunità, libertà e conseguenze molto diverse di cui la valutazione di utilità, o di felicità, non tiene direttamente conto. Eppure un insieme con pari valori di utilità può accompagnarsi o meno a gravi violazioni dei diritti individuali. Qualunque cosa accada però, negli esercizi di valutazione l’approccio utilitaristico richiede di ignorare le disuguaglianze e le violazioni dei diritti e delle libertà personali, e di giudicare le alternative soltanto dai totali di felicità generati da ciascuna. Pare strano questo tenace rifiuto di attribuire un’importanza intrinseca a qualunque cosa esuli dal benessere o dalla felicità nel valutare stati o politiche alternative.
Il limite della prospettiva utilitaristica è aggravato inoltre dall’interpretazione del benessere individuale in base alla sola felicità o al “piacere meno il dolore” (per dirla con Jeremy Bentham), una visione angusta e restrittiva in particolare degli aspetti interpersonali delle privazioni. Per esempio paragonare la felicità – o la forza dei desideri – può essere una guida parecchio ingannevole ai confronti interpersonali tra la nostra vita e quella altrui, poiché aspettative e sopportazione, sofferenze e piaceri tendono tutti a venir adattati alle nostre circostanze, in particolare per renderci tollerabile la vita in mezzo alle avversità.
Alla metrica utilitaristica succede di essere profondamente ingiusta verso le persone che subiscono privazioni persistenti, i perdenti delle società stratificate, le minoranze oppresse da società intolleranti, i lavoratori precari che vivono in un mondo di incertezza e quelli sfruttati da certe industrie, le casalinghe sottomesse in culture profondamente sessiste. Ai più miseri può mancare il coraggio di desiderare un cambiamento radicale e tendono spesso ad adattare le proprie aspettative e aspirazioni a quanto sembra loro fattibile. Si allenano a trarre piacere da ogni grazia ricevuta.
Gli adattamenti hanno però l’effetto incidentale di falsare la scala delle utilità. Nella metrica del piacere, o dell’appagamento dei desideri, gli svantaggi di chi si accontenta delle proprie sventure possono apparire minori di come emergerebbero da un’analisi più oggettiva delle privazioni e dell’assenza di libertà. Riconciliarsi con i propri svantaggi o accontentarsene è ben diverso dal non avere svantaggi. Perciò, come ho scritto in Lo sviluppo è la libertà e L’idea di giustizia, gli indicatori della performance sociale basati sulla felicità sono così problematici.
Però trascurare simili valutazioni delle società e della vita sociale crea a sua volta un problema perché, fuori dalla filosofia utilitaristica, usiamo spesso il termine “felicità” in sensi più ampi. L’espressione “un paese felice” riflette una forte approvazione e lungo tutta la nostra storia la felicità è stata evocata come la cosa più importante della vita. Ne parla Socrate e, con il suo sigillo, Aristotele ha sancito il perseguimento dell’eudemonia. C’è forse un conflitto con la mia precedente critica all’affidarsi alla felicità per giudicare dell’andamento di una società? Direi di no, perché l’ideale di felicità può essere interpretato in modi diversi. Qui è utile ricordare quella che Gramsci chiamava “filosofia spontanea” per capire la natura complessa di quello che intendiamo quando usiamo la parola “felicità” nella comunicazione quotidiana.
Le diamo un senso più generale della definizione utilitaristica “piacere meno dolore”.
Se vi chiedo, per esempio, se volete pranzare con me e rispondete “ne sarei felice”, non vi obietto che la domanda era un’altra e che volevo sapere se eravate d’accordo o meno per venire a pranzo. Sarebbe assurdo, perché nel dichiarare che ne sareste felici avete già comunicato il vostro assenso. Certo, si può dare una definizione tecnica di felicità, come gli utilitaristi e chiunque altro, ma se una persona risponde “ne sarei felice”, non è detto che si riferisca a quella definizione e le sue parole vanno esaminate nel loro contesto, secondo le regole che ne governano l’uso nella normale conversazione.
Molti filosofi riterrebbero una simile attenzione alle regole sull’uso del linguaggio in linea con il pensiero di Ludwig Wittgenstein nelle opere più tardive, come le Ricerche filosofiche. Sarebbe corretto, tutto sommato, ma come ho già avuto occasione di dire, le radici si trovano nella ricerca filosofica svolta con notevole potenza da Antonio Gramsci, che ne è stato il pioniere e ha influenzato Wittgenstein attraverso il grande economista Piero Sraffa, amico di entrambi (e, per una felice coincidenza, mio insegnante a Cambridge). L’interesse filosofico di Sraffa risaliva alla sua collaborazione con Gramsci all’Ordine nuovo, il famoso settimanale fondato da Gramsci e chiuso da Mussolini. Ci accorgiamo delle regole che governano la nostra comunicazione, sosteneva Gramsci, attraverso il linguaggio che impariamo ad usare e questo rientra in quella che chiamava “filosofia spontanea”.
Distinguerei quindi il senso benthamiano ristretto di felicità reso popolare dalla filosofia utilitaristica dal senso che ha nella filosofia spontanea. C’è un rapporto, ovviamente tra provare piacere nel fare qualcosa (tutto ben considerato) e la felicità nell’accezione benthamiana. L’infelicità in senso stretto può essere il risultato della frustrazione dovuta al non poter fare quello che desideriamo, anche se la ragione del nostro desiderio ha poco o nulla a che fare con il perseguimento della felicità definita come piacere. Volete aiutare, mettiamo, una persona poverissima perché pensate che sia la cosa giusta. Non è la ricerca della vostra felicità a motivarvi e neppure l’idea che fare la costa giusta tenderà a rendervi più felici. C’è una differenza tra aiutare qualcuno perché è la cosa giusta e aiutarla per procurarsi, anche indirettamente, una gioia personale. Nel primo caso, la gioia è un aspetto secondario mentre l’etica non lo è: la felicità in senso benthamiano può essere implicata indirettamente, ma non perché essa sia il vostro unico scopo, e nemmeno quello principale: procurare un aiuto a chi ne ha bisogno.
L’infelicità che proviamo oggi per il tremendo disastro economico in Europa e altrove non ha soltanto una componente benthamiana nella mancanza di piacere e nella presenza di dolore, ma anche svariati motivi di disapprovazione: la libertà umana negata da fenomeni come la disoccupazione di massa; l’oltraggio etico davanti a vite maltrattate da banche e istituti finanziari e anche la profonda delusione per l’incapacità dei governi nazionali e delle istituzioni internazionali di adottare politiche al contempo intelligenti e compassionevoli. Se dico che quanto accade in Europa mi rende infelice, non sto comunicando per forza una mia personale perdita di utilità benthamiana, ma un paniere ben più capiente di consapevolezze e di conoscenze che mi fanno disapprovare la gestione della crisi in questi ultimi anni.
Abbiamo ragione di essere molto infelici per l’Europa anche dal punto di vista della ben più capiente filosofia spontanea di Gramsci. Il lamento di Dante può esprimere l’infelicità per quanto siamo vulnerabili oggi, sennonché il “poco vento” è un’immane bufera causata dal cattivo operato dei mercati e da una lunga serie di cattive politiche adottate dagli stati e da istituzioni statali e regionali. Siamo caduti, certo, ma abbattuti da una violenta tempesta di mercati manipolati e di madornali errori dei nostri governanti.
Quanto alla disuguaglianza, vicende contrastanti e disparate hanno spaccato la popolazione. Nella brutale recessione che il mondo, e l’Europa in particolare, sta attraversando, c’è un numero enorme di persone disoccupate, dai redditi drasticamente ridotti, che non possono permettersi beni e servizi essenziali e hanno poca libertà di gestire la propria vita, mentre altre prosperano. E’ tipico di una crisi economica suscitare forti divisioni, eppure il senso di infelicità per qualcosa di molto sbagliato può essere provato sia da quelli colpiti dalla lunga recessione che da quelli immuni che ne sono comunque oltraggiati. La povertà, la miseria non si condividono, l’oltraggio sì e, per l’infelicità in senso lato, basta e avanza.
Perché l’Europa è tanto nei guai? In effetti ha due problemi da affrontare: l’inflessibilità della moneta unica nella zona euro e la gestione della recessione attraverso la politica di austerità scelta da potenti leader politici e finanziari europei. Ne ho già scritto altrove (“Cosa ti è successo, Europa?” Domenica – Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2012, ndr) e sarò breve. Nella zona euro, l’integrazione e l’unione monetaria realizzate prima di avere il sostegno di una più stretta unione politica e fiscale non suscitano solo infortuni economici ma anche rapporti ostili tra i popoli dei vari paesi.
Di conseguenza, lo scenario di crisi e di salvataggi in cambio di tagli draconiani ai servizi pubblici – questioni economiche sulle quali tornerò – ha suscitato malumori. Se errori nella successione delle misure prese e nelle decisioni politiche contingenti hanno peggiorato il disamore internazionale per l’Europa (è stato così, a giudicare dalla retorica politica sentita di recente con forme diverse da nord a sud), è il pegno da pagare per la via che si è imboccata. La visione di un’unità europea crescente che era nata a Ventotene e a Milano negli anni Quaranta è stata assecondata male da piani di salvataggio che non solo hanno precipitato milioni di cittadini in una miseria nera, ma hanno anche generato una divisione di cui si poteva far a meno tra tedeschi prepotenti, secondo i greci, e greci fannulloni, secondo i tedeschi.
L’analogia, spesso invocata, con i sacrifici dei tedeschi per unire le due Germanie è del tutto fuorviante. In parte perché i sacrifici coordinati dal cancelliere Kohl erano intelligenti e progettati bene, e soprattutto perché al momento tra i paesi europei non esiste il senso di unità nazionale che predisponeva i tedeschi ad accettarli. Inoltre ricadevano sulla parte ricca del paese dove il cancelliere era basato: questo fatto ha una qualità politica assai diversa dei tentativi di imporre una rigida austerità ai paesi più poveri dell’Europa meridionale da parte di leader politici che vivono in regioni più prospere.
Vengo ora alla crisi economica globale e agli sforzi europei per rimediare alla propria con l’austerità. La crisi che ha travolto il mondo nel 2008 non è nata in Europa, ma negli Stati Uniti e la recessione che ne è conseguita negli Stati Uniti ha avuto ripercussioni sul resto del mondo, in particolare in Europa. E’ iniziata negli Stati Uniti, dove il settore finanziario si era comportato in modo estremamente irresponsabile e avventato. Il mondo aveva molte ragioni di essere infelice e scontento dell’economia statunitense, data l’eliminazione graduale – dai tempi del presidente Reagan – di quasi tutti i controlli sensati che regolamentavano le istituzioni finanziarie e le assicurazioni. Nel settore finanziario, i giocatori di serie A fecero un sacco di soldi, per se stessi innanzitutto, con esiti scintillanti ai quali corrispondevano prassi inaccettabili. Gli americani hanno causato la crisi, ma sono stati più veloci degli europei a temperarne l’intensità con uno stimolo fiscale. Contagiata dalla recessione, l’Europa adottò invece una filosofia immensamente contro-produttiva di redenzione attraverso l’austerità.
E’ difficile vedere nell’austerità una soluzione economica assennata all’attuale malaise europeo. Non è neppure un buon mezzo per ridurre il deficit pubblico. Il pacchetto di provvedimenti richiesto dai leader finanziari è stato decisamente anti-crescita. Nella zona euro, la crescita è stata così tentennante e il prodotto interno lordo è calato così tanto che l’annuncio di una crescita zero sembra addirittura una “buona notizia”. Sebbene la Gran Bretagna non sia sotto il potere finanziario dei leader della zona euro, ha scelto deliberatamente la strana filosofia della ripresa attraverso l’austerità, con lo stesso triste risultato. E’ una politica fallimentare in Europa come lo è stata negli Stati Uniti negli anni Trenta e più recentemente in Giappone (una politica di contrazione che il primo ministro neo-eletto Shinzo Abe sta cercando di ribaltare).
Nella storia del mondo abbondano invece le prove che il modo migliore per ridurre il deficit non è l’austerità, ma una rapida crescita economica che generi reddito pubblico con il quale colmare il deficit. Dopo la seconda guerra mondiale, gli enormi deficit europei sono in gran parte spariti grazie a un veloce sviluppo; è successo qualcosa di simile durante gli otto anni della presidenza Clinton, iniziata con un deficit enorme e conclusasi senza, e in Svezia tra il 1994 e il 1998. Oggi la situazione è diversa, perché in aggiunta alla recessione la disciplina dell’austerità viene imposta per ridurre il deficit a molti paesi con un tasso di crescita zero o negativo. Creare sempre più disoccupazione laddove c’è una capacità produttiva inutilizzata è una strategia bizzarra, e non basta ai padroni della politica europea dire che non si aspettavano forti cali di produzione e alti e crescenti tassi di disoccupazione. Perché mai non se l’aspettavano? Da quale idea dell’economia si fanno guidare? Di sicuro la qualità intellettuale del loro pensiero è un motivo di infelicità. Non si tratta soltanto di avere un’etica solidale, ma anche un’epistemologia decente.
Dire che in caso di recessione la politica dell’austerità rischia di essere contro-produttiva può sembrare una critica sostanzialmente “keynesiana”.
John Maynard Keynes ha sostenuto in modo convincente che durante un eccesso di capacità produttiva dovuto alla scarsa domanda del mercato, tagliare la spesa pubblica rallenta l’economia e accresce la disoccupazione invece di diminuirla. Gli va riconosciuto il grande merito di aver fatto capire questo punto fondamentale ai responsabili politici di ogni tendenza. Sarebbe sensato avvalerci delle buone ragioni di Keynes, ormai fanno ormai parte del pensiero economico comune (anche se sono ignote ai leader europei), ma per quanto riguarda la totale inadeguatezza dell’austerità in Europa, ce ne sono altre.
Dobbiamo andare oltre Keynes e chiederci a che cosa serva la spesa pubblica, oltre a rafforzare la domanda del mercato, qualunque ne sia il contenuto. Il risentimento – l’infelicità – di tanti europei per i tagli feroci ai servizi pubblici e per l’austerità indiscriminata non si basa soltanto e neppure primariamente su un ragionamento keynesiano. Fatto altrettanto importante, se non di più, quella resistenza esprime un’opinione costruttiva interessante dal punto di vista sia politico che economico. Parla di giustizia sociale, di ridurre l’ingiustizia invece di aumentarla. I servizi pubblici sono apprezzati per ciò che forniscono in concreto alle persone, soprattutto alle più vulnerabili, e in Europa sono stati ottenuti con decenni di lotta. Tagliarli spietatamente significa rinnegare l’impegno sociale degli anni Quaranta che ha portato alla previdenza e alla sanità pubblica in un periodo di cambiamento radicale. Questo continente ne è stato il pioniere, ha dato una lezione di responsabilità sociale poi imparata nel resto del mondo, dal Sud-est asiatico all’America latina.
Keynes parlò pochissimo di disuguaglianza economica; sugli orrori della povertà e delle privazioni fu di una reticenza straordinaria. Non lo interessavano granché le esternalità e l’ambiente, trascurò del tutto “l’economia del benessere” di cui si occupava invece il suo rivale e antagonista A.C. Pigou. Come ho scritto sulla New York Review of Books – persino Bismarck nell’Ottocento si interessò di sicurezza e di giustizia sociale più di quanto avrebbe fatto Keynes. Gli amici keynesiani mi accusarono di irriverenza (anche quelli della Banca d’Italia), di aver insultato Keynes e vollero farmi ritrattare. Dimenticavano che, sebbene fosse un leader conservatore, Bismarck aveva molto da dire sull’importanza dei servizi sociali.
Per finire, vorrei accennare alla riforma economica di cui molti paesi europei, e non solo la Grecia o l’Italia, hanno senz’altro un gran bisogno. Uno degli aspetti peggiori dell’austerità è stato di rendere questa riforma impraticabile confondendo due programmi: l’austerità dei tagli spietati e la riforma di una cattiva amministrazione (evasione fiscale diffusa, favori concessi da funzionari pubblici per lucro personale e anche insostenibili convenzioni sull’età pensionabile). I requisiti della presunta disciplina finanziaria li hanno amalgamati, sebbene qualunque analisi della giustizia sociale porti a politiche distinte per ciascun programma.
L’amalgama è il frutto di una confusione intellettuale che porta al disastro politico perché collega un bisogno forte e sensato a una follia intempestiva, e nelle campagne politiche unisce gli oppositori dell’austerità a quelli delle riforme indispensabili. L’Europa deve cambiare ora. Nessun paese scaccerà da solo la potente illusione di cui i leader politici sembrano prigionieri, né la Grecia, né il Portogallo e nemmeno l’Italia, eppure bisognerà trovare una voce collettiva per porre fine a tanta miseria e a tanta infelicità.
Chiedo scusa, mi sono dilungato sull’economia mentre volevate sentir parlare di felicità. Mi dispiace, a mia difesa però va detto che per arrivare a un’Europa felice, dobbiamo prima discutere di molte cose infelici. Avrei preferito che non fosse così.
Tratto da Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2013