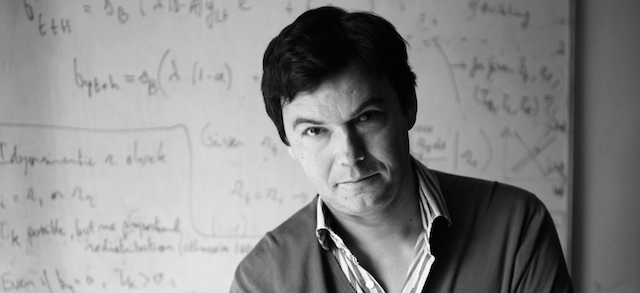Un interessante riflessione di Sandro Trento
Il 17 giugno Dario Di Vico ha pubblicato un articolo sul “Corriere della sera” in cui proponeva tre cause come spiegazioni alternative della deludente crescita del PIL italiano, anche nell’attuale fase di ripresa: 1) bassa produttività del lavoro e del capitale; 2) polarizzazione del sistema delle imprese fra imprese che competono e imprese che rischiano di chiudere; 3) ristagno della domanda interna. Trento ribatte, a nostro avviso giustamente, che la crisi è strutturale, non congiunturale. È una questione di modello, di sistema, e come tale va affrontata
Suggerire, oggi, che ci possa essere una singola “grande” causa della bassa crescita italiana rischia di dare un segnale sbagliato. Trovata la singola causa si potrebbe pensare che sia semplice poi definire un piano per lo sviluppo. Purtroppo la malattia italiana è molto più cronica e articolate, e per questo molto difficile da curare.
Provo a fare alcune osservazioni. La questione – come ripetiamo da tempo – non è congiunturale ma strutturale.
L’Italia non cresce da almeno quindici anni, già prima della grande crisi del 2008-2009. Sarebbe sbagliato pensare che sia stata l’ecatombe mondiale del 2008 a provocare i nostri problemi. Almeno a partire dalla metà degli anni ’90 la nostra economia ha perso la spinta alla crescita. Il nodo è stato il cambio di regime imposto dalla moneta unica: ci siamo trovati a dover competere con i concorrenti tedeschi senza avere: le loro istituzioni, la loro capacità competitiva (produttività), il loro posizionamento settoriale, la loro presenza sui mercati mondiali. Siamo rimasti intrappolati in un modello economico non più adeguato a cogliere le sfide del nuovo scenario. Basti pensare al grave ritardo che abbiamo accumulato nell’introduzione delle nuove tecnologie digitali e soprattutto all’incapacità di definire nuovi modelli di business e di entrare in nuovi settori e nuovi mercati. Il vecchio modello era fondato su complementarità tra fattori produttivi, tra istituzioni, tra mercati, tra modelli culturali di comportamento. Abbandonare un modello per passare a uno nuovo, più adatto a cogliere le opportunità del nuovo scenario, è molto difficile, richiedere azioni su più fronti: rinunciare alle vecchie complementarità per farne sorgere di nuove. Ci vuole tempo, determinazione e soprattutto una classe dirigente con una visione condivisa del modello futuro verso cui si vuole tendere. Tutto questo è mancato e ancora manca. Verso dove vogliamo andare? Verso un modello di mercato aperto? Questo forse lo pensano parte dell’industria manifatturiera, quella più dinamica e parte delle élite globaliste, ma la pancia del paese forse spera ancora di sopravvivere nel vecchio “piccolo mondo antico”. C’è poi chi propone un modello che definirei di irrealistico capitalismo scandinavo: tenere la spesa pubblica, politiche di accrescimento del perimetro pubblico, ritorno alle protezioni nel lavoro, politiche industriali e così via. Questo è irrealistico anche perché i paesi scandinavi da molto tempo non sono più così e soprattutto, perché l’Italia ha una grande industria manifatturiera che necessità mercati aperti. Abbiamo fatto riforme incomplete anche perché non sappiamo cosa vogliamo diventare. Si è liberalizzato al margine il mercato del lavoro ma non si è fatto altrettanto per far funzionare il mercato del capitale (al singolare e non al plurale). Ci torno tra poco su questo punto.
Oggi ci troviamo in una fase nella quale la ripresa dipende essenzialmente dalla domanda estera ma soprattutto dalla domanda estera dei paesi extra-europei. L’area dell’euro è ferma a tassi anemici. E il 60 per cento delle imprese esportatrici italiane continua ad esportare solo in Europa. Se l’Europa non riparte questa fetta enorme del nostro sistema produttivo non avrà chance si sviluppo. Con la crisi del 2008-2009 c’è stato un mutamento profondo delle nostre “catene del valore”: la crisi bancaria ha fatto sì che il credito commerciale tornasse ad essere ancora più importante di quanto non fosse prima, molte grandi imprese hanno a quel punto selezionato duramente i loro fornitori e alcune grandi imprese hanno deciso di internalizzare alcune fasi che prima davano in outsourcing. In fin dei conti la chiusura da parte della FIAT di Termini Imerese è stato un esempio di questo processo. La capacità di trascinamento della grande impresa rispetto alle piccole e medie imprese si è molto ridotta da quel momento in poi.
Si è ristretto il peso della manifattura e oggi il peso della manifattura sul PIL italiano è molto più piccolo. La capacità di trascinamento della crescita da parte della manifattura è più bassa in Italia che in Germania (ne parla anche il “Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi”).
Vi è un problema di legami tra manifattura e terziario.
C’è il nodo produttività che è sempre lì. Non riusciamo a far crescere la produttività. Non sappiamo usare le tecnologie digitali, questo per varie ragioni: la nostra forza lavoro non è abbastanza istruita; le imprese sono troppo piccole; siamo concentrati in settori nei quali l’”informazione” non è un bene strategico; non abbiamo analisti di mercato capaci di usare i “big data” (qui c’è un buco formativo delle nostre università). Ma c’è anche un effetto perverso delle riforme del lavoro. La precarietà del lavoro fa calare la produttività delle imprese.
Il punto vero però è che la produttività in un paese avanzato cresce soprattutto attraverso la nascita di nuove imprese, più innovative di quelle esistenti. E’ questo processo di entrata di nuove imprese e di morte di quelle meno efficienti che fa salire la produttività. In Italia questo meccanismo di ricomposizione e di riallocazione delle risorse non funziona. Mancano a mio avviso nuovi imprenditori (oggi servono imprenditori con elevato capitale umano), manca la finanza capace di finanziare chi ha idee nuove ma non ha collateral.
Last but not least, c’è una domanda interna che langue. La manifattura è più piccola. La quota di imprese manifatturiere che sa agganciarsi alla ripresa mondiale è solo una parte molto piccola di questo settore manifatturiero (più piccolo rispetto a prima), una fetta rilevante delle imprese esportatrici vende i propri prodotti non in Cina ma al di là della Alpi, dove la domanda non è che sia molto più dinamica. Serve quindi una ripresa della domanda interna per far ripartire la grande massa dell’industria e il terziario antico di cui disponiamo.